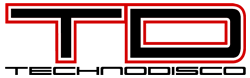Lanciato nel 2007 dalla Cocoon Recordings di Sven Väth, l’israeliano Shlomi Aber è riuscito a raggiungere, in un tempo ragionevolmente stretto, tappe importanti per la carriera di un DJ e produttore. Se “Sea Of Sand”, firmato con l’amico Guy Gerber, servì come trampolino di lancio per irradiare una specie di Tech Progressive House, “Crop Duster”, “Moods”, (su Renaissance) e “Freakside” e “Tokyo Shanghai/Quivery” (su Ovum) hanno decretato l’affermazione su larga scala di questo intraprendente personaggio residente a Tel Aviv. Per il suo (secondo) album, dopo “State Of No One” del 2007, realizza qualcosa di decisamente ricco a livello creativo e qualitativo, pur ripercorrendo l’ideale linea biologica della House e della Techno. Il titolo appare subito chiarificatore, e ci fa capire quali siano le fondamenta dell’intero elaborato. L’intento di Aber è quello di far rivivere in epoche moderne lo spirito della House di Chicago e della Techno di Detroit e, nonostante qualche lieve incertezza, la missione può ritenersi compiuta. Se si pensa alla città che diede i natali a DJ International, Hot Mix 5 o Trax Records, le varie “Taped And Gorgeous”, “Tap Order”, “Slow Dancer” e “Propaganda” suoneranno senza dubbio come i brani che meglio tributano quel particolare periodo di esordi. Se invece si desidera sudare coi meccanicismi ritmici della Motor City (all’inizio detta House made in Detroit) è necessario puntare alla Techno squisitamente millsiana di “Groove Mechanism”, alle inclinazioni Deep alla Maurizio o Basic Channel di “New York Dreamer” e di “Create Balance” (un sunto della produzione su Axis e Purpose Maker) ed al tripudiante sound di “Sketches”, col featuring di Kenny Larkin. Bellissimi i confronti che si susseguono in “Black Funk Hi”, tra samples di origine Funk e gonfiori tipicamente Techno, che creano un sottile parallelismo tra scuola francese (Cassius, Daft Punk) e giapponese (Kagami, Tasaka). Il finale è clamoroso grazie a “Basic Roots” che fa riecheggiare la Techno spirituale di Underground Resistance (il riferimento, in questo caso, corre a “Jaguar”, l’evergreen di The Aztec Mystic). Quella di Aber non è sterile voglia di emulazione o di scimmiottamento, ma desiderio di far palpitare i cuori ancora una volta con un suono senza tempo, che è stato e che continuerà ad essere indicato come l’inizio assoluto di qualcosa che continua ad evolversi giorno dopo giorno.
Lanciato nel 2007 dalla Cocoon Recordings di Sven Väth, l’israeliano Shlomi Aber è riuscito a raggiungere, in un tempo ragionevolmente stretto, tappe importanti per la carriera di un DJ e produttore. Se “Sea Of Sand”, firmato con l’amico Guy Gerber, servì come trampolino di lancio per irradiare una specie di Tech Progressive House, “Crop Duster”, “Moods”, (su Renaissance) e “Freakside” e “Tokyo Shanghai/Quivery” (su Ovum) hanno decretato l’affermazione su larga scala di questo intraprendente personaggio residente a Tel Aviv. Per il suo (secondo) album, dopo “State Of No One” del 2007, realizza qualcosa di decisamente ricco a livello creativo e qualitativo, pur ripercorrendo l’ideale linea biologica della House e della Techno. Il titolo appare subito chiarificatore, e ci fa capire quali siano le fondamenta dell’intero elaborato. L’intento di Aber è quello di far rivivere in epoche moderne lo spirito della House di Chicago e della Techno di Detroit e, nonostante qualche lieve incertezza, la missione può ritenersi compiuta. Se si pensa alla città che diede i natali a DJ International, Hot Mix 5 o Trax Records, le varie “Taped And Gorgeous”, “Tap Order”, “Slow Dancer” e “Propaganda” suoneranno senza dubbio come i brani che meglio tributano quel particolare periodo di esordi. Se invece si desidera sudare coi meccanicismi ritmici della Motor City (all’inizio detta House made in Detroit) è necessario puntare alla Techno squisitamente millsiana di “Groove Mechanism”, alle inclinazioni Deep alla Maurizio o Basic Channel di “New York Dreamer” e di “Create Balance” (un sunto della produzione su Axis e Purpose Maker) ed al tripudiante sound di “Sketches”, col featuring di Kenny Larkin. Bellissimi i confronti che si susseguono in “Black Funk Hi”, tra samples di origine Funk e gonfiori tipicamente Techno, che creano un sottile parallelismo tra scuola francese (Cassius, Daft Punk) e giapponese (Kagami, Tasaka). Il finale è clamoroso grazie a “Basic Roots” che fa riecheggiare la Techno spirituale di Underground Resistance (il riferimento, in questo caso, corre a “Jaguar”, l’evergreen di The Aztec Mystic). Quella di Aber non è sterile voglia di emulazione o di scimmiottamento, ma desiderio di far palpitare i cuori ancora una volta con un suono senza tempo, che è stato e che continuerà ad essere indicato come l’inizio assoluto di qualcosa che continua ad evolversi giorno dopo giorno.